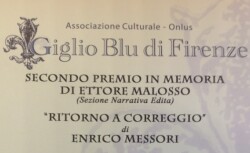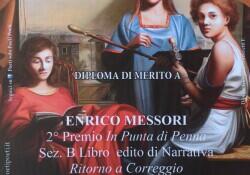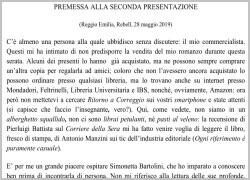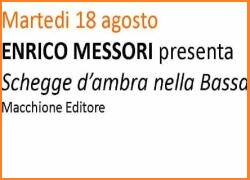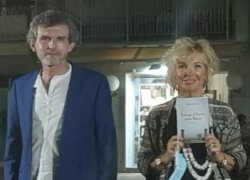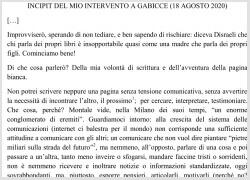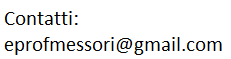Benvenuto nel sito di Enrico Messori
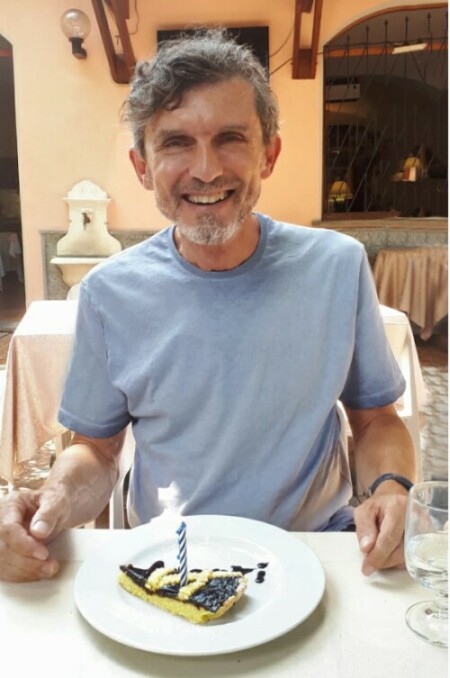
Chi sono
"Sui curricula non c’è spazio per le passioni, i sogni, i fallimenti. Per la forza dei desideri."
Paola Calvetti, Olivia. Ovvero la lista dei sogni possibili, Mondadori, 2013.
Sono nato a Modena il 18 agosto 1955 e vivo a Correggio, in provincia di Reggio Emilia.
Dopo gli studi classici, mi sono laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena; sotto la guida del mio Maestro, il prof. Francesco Marani, ho perfezionato gli studi nello stesso Ateneo modenese e, successivamente, presso le Università di Parma e di Camerino.
Nel corso degli anni Ottanta (a partire dal 1979) ho insegnato Istituzioni di diritto privato presso l'Università Popolare di Bolzano, città che ricordo con simpatia nel romanzo Ritorno a Correggio.
Nel 1992, l'editore Joppolo ha pubblicato un mio manuale di educazione civica: Persona e Collettività, che ho scritto pensando di essere in difetto verso i miei allievi: sono più spesso loro ad affezionarsi ai docenti che non il contrario, come scrive, in una bellissima pagina della sua autobiografia, Elias Canetti.
Nel 1994 è uscito dall'editore napoletano Italibri un mio libro di sparse cose e capitoletti intitolato Davanti al sasso. L' amico Pasquale Maffeo lo ha così descritto "[...] Nella duplice partizione di 'Lettere' e 'Taccuino', il volume evoca l'immagine della libra, due piatti sospesi, carichi di doni, che nel peso si bilanciano a configurare l'offerta dell'anima e l'offerta della mente [...]".
Nel 1997, insieme con il giornalista Romano Bracalini, ho curato la pubblicazione, per Mucchi editore in Modena, degli Atti del Convegno Nazionale "Autorità e Democrazia", organizzato con il patrocinio dell'IRRSAE dell'Emilia-Romagna e con l'appoggio della rivista Giurisprudenza Pugliese, diretta dal compianto prof. Domenico Conserva, mio docente a Camerino.
Per diversi anni ho collaborato con la Casa Editrice Tramontana, scrivendo numerosi articoli giuridici. Miei giovanili e circoscritti contributi di dottrina hanno trovato ospitalità nell'Archivio Giuridico "Filippo Serafini" e nella Rivista del Notariato.
Per oltre 30 anni, ho insegnato "diritto ed economia politica" nell'Istituto Tecnico "Luigi Einaudi" della mia città. I miei studenti hanno raggiunto ogni anno buoni risultati utilizzando, oltre al manuale adottato, la cui tessitura è essenziale per un'adeguata formazione, inediti materiali didattici da me predisposti.
Pur essendo in pensione, mi ritengo ancora un insegnante che scrive. È l'essere insegnante un elemento costitutivo della mia identità personale e anche sovra-individuale. La coscienza di questa identità mi fa sentire di appartenere a un noi: noi insegnanti. La cattedra, dietro la quale mi sono seduto, ma "nella quale" non sono mai "salito", continuerà difatti a rimanere, per me, simbolo del dovere prescritto dall'art.4, 2° co., della Costituzione, nonostante il dettaglio degli "scudi tre di mensuale" (parole che prendo a prestito da una gustosa descrizione di Vittorio Alfieri). Ma questa non è l'unica identità collettiva che sento, ovviamente. Se vado, che so, negli USA a trovare la mia primogenita, che là vive e lavora come architetto, mi vien fatto di pensare al famoso incontro tra Sordello e Virgilio: "O mantovano, io sono Sordello /della tua terra! E l'un l'altro abbracciava". I miei tanti ex-studenti venuti da lontano sanno bene che è anche da quel pensiero che ho concepito e cercato di misurare l'esercizio del mio insegnamento, confidando nel carattere effusivo della cultura, come testimonia Platone nella Settima lettera..
I miei libri
 Sotto il manto di Elias
Sotto il manto di EliasCon questa seconda raccolta poetica, Enrico Messori prosegue nel suo intento di tratteggiare creativamente il proprio "lessico famigliare". E, se nel primo tempo il Tema era la Madre, qui il canto è rivolto al Padre, innanzitutto; ma, inevitabilmente, anche agli altri "parenti" (e, soprattutto, alla Moglie). La cifra dello stile è la (sua) poetica ormai assestata. Lo spiega l'Autore stesso, lasciando tuttavia al Lettore il diritto-dovere di tirare le conseguenze. Ecco quindi i componimenti d'amore e di pena, disdegno e di cortesia, nei quali le passioni sono indirizzate a persone e a oggetti che possano reggere l'urto (tendenzialmente) distruttivo. La "Retorica", convocata qua e là sapientemente dalla Cultura del Poeta, attenua la portata esplicita dei sentimenti per poter sublimare i rapporti. E, tuttavia, oltre le citazioni postmoderne programmaticamente delusive, affiora la spinta intenzionale dell'Autore verso i dettagli delle persone e degli oggetti che, soltanto, possono aiutare l'Arte a parlare della Realtà. E, anche quando la versificazione paga un eccessivo tributo al linguaggio della (nostra, pur umanissima) quotidianità, la poesia di Messori insegue la resa icastica del mondo dell'Anima e della Natura. Sicché, scorrendo i componimenti della raccolta, si capisce che Messori si copre col manto di Elia(s) perché la sua Poesia possa parlare e essere intesa senza che si perda la Voce (il Soffio, lo Pneuma, lo Spirito, il senso del Suono e il suono del Senso) del Mondo.
(Prefazione di Rino Caputo, storico e critico della letteratura)
Leggi la recensione su librierecensioni.com
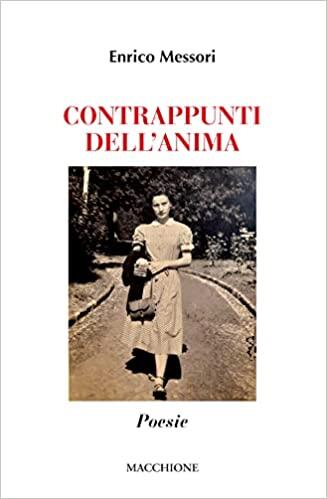 Contrappunti dell'anima
Contrappunti dell'animaLa poesia di Enrico Messori può essere configurata come un insieme di "contrappunti dell'anima", un sintagma musicale, innanzitutto, dove il senso è rintracciabile già nel suono. L'Autore dichiara apertamente la sua Tradizione, che è la lirica italiana moderna e contemporanea, anche se non ne fa ostentata dimostrazione. A Messori interessa la sinestesia ovvero l'espressione dell'anima poetica all'incrocio delle arti... La raccolta è pervasa, direttamente e indirettamente, di afflato familiare, le figlie bambine e poi adulte, ad es., avvisaglia perspicua del "lessico famigliare" che Enrico Messori fa rifluire nella sua poesia (Rino Caputo).
I versi di Enrico Messori affabulatori, fantastici, eppure nel contempo così legati a valori quotidiani, alle radici dell'io, alle reminiscenze, alle tenerezze, agli abbandoni che li rendono profondamente umani pur in questa continua pulsione intimistica che pare erigersi sulle cose, scavalcarle con i soffi del sogno, ricostruirle in visioni ora tenui ora rabbiose, sempre penetrate dall'energia che vive nelle speranze dell'autore (Giulio Panzani).
Leggi la recensione su librierecensioni.com
G. Guidotti, "Una raccolta intimistica nel ricordo tenero della madre". Raffinata ricerca linguistica del poeta correggese Enrico Messori, Gazzetta di Reggio, 2 marzo 2023.
Questa raccolta ha vinto il Diploma di Merito "Lettura Poetica" al XII Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa "Città di Sarzana" (dicembre 2024):

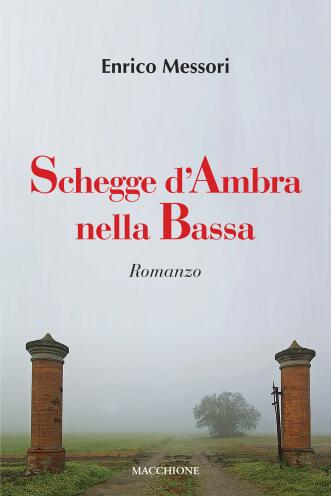 Schegge d'Ambra nella Bassa
Schegge d'Ambra nella BassaSiamo nel 2016. Damiano (la voce narrante) e Abdon sono due cinquantenni di provincia, amici sin dall'infanzia: il primo è un impiegato, il secondo fa il sarto. Damiano vive solo. Abdon abita con la sorella, Ida, anche lei sarta; la vita dei due fratelli è stata segnata anni addietro da tragiche scomparse.
In un non meglio identificato paese della Bassa Reggiana, Damiano e Abdon attraversano esperienze che producono in loro movimenti di tristezza e di gioia, di sconforto e di euforia. La poesia, la buona cucina, gli antichi miti animano e incorniciano le storie d'amore che ora riemergono dal passato, ora si presentano con l'inattesa freschezza del presente.
Affiora, dal respiro etico del romanzo, la spiccata capacità dell'autore di osservare i moti dell'animo dei personaggi, anche femminili. Kora e Miriam sono donne ben diverse l'una dall'altra, accomunate però da sogni di libertà e di passioni. Sul filo di un'ironia sottile e garbata trovano infine sapiente collocazione personaggi minori, che apportano alla storia originali effetti coloristici e spunti di non banale riflessione.
La resina, il profumo, il colore, la luce dell'ambra connettono tra loro i particolari del congegno romanzesco, portato all'epilogo nel successivo anno bisestile: il 2020, scosso da un vento di rapina.
Leggi la recensione su librierecensioni.com
G. Guidotti, "Alla ricerca di noi stessi in un mondo di insicurezze", sub "Il libro della settimana", Gazzetta di Reggio, 29 ottobre 2020.
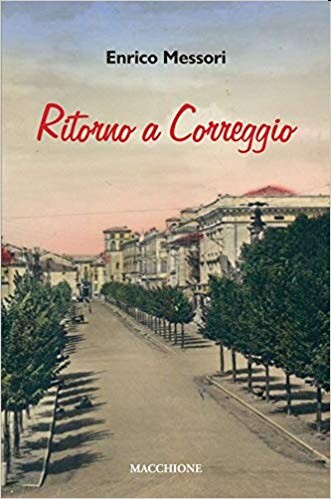 Ritorno a Correggio
Ritorno a CorreggioQuesto romanzo costituisce un paradigma della vita tra gioventù e maturità, con slanci, delusioni, felicità, dolori. Le conversazioni - peraltro virtuali - tra il protagonista e un suo ex professore hanno la veste dei dialoghi del Simposio di Platone o di qualche Operetta Morale di leopardiana memoria. Il "rischio" di una sorta di romanzo filosofico viene comunque annullato dalla presenza concreta della città di Correggio, storico comune della provincia reggiana, che rende personaggi e vicende più tracciabili, in una terra amata e affettuosamente descritta. A Correggio si vive, da Correggio si parte per vacanze, speranze, ambizioni, a Correggio si torna (sempre) per ritrovare il senso e forse la bellezza della vita reale. Correggio diventa, così, luogo dell'anima, in cui ognuno può riconoscersi.
Leggi la recensione su librierecensioni.com
G. Guidotti, "Letteratura e tanta filosofia nel romanzo di Messori", Gazzetta di Reggio, 31 ottobre 2019.
https://www.gazzettadireggio.it/reggio/cronaca/2019/02/15/news/il-libro-di-enrico-messori-oggi-all-hotel-president-1.17760593
TANTO PER DIRE
NOTA SUI LINGUAGGI DELL’OPERA IN VERSI E DELL’OPERA IN PROSA
(In occasione dell'uscita da Macchione Editore della mia seconda raccolta di poesie Sotto il manto di Elias, marzo 2025)
Diverse le sintassi, diversi i tessuti, certamente. E forse il poeta è, innanzi tutto, un lettore lentissimo, perché gusta (quando ritenga lo meritino, altrimenti si ferma) le singole "righe", le singole "pagine", manifestando, così, amore per la parola e per il suo senso profondo (1). Ma a sorreggere la tesi che tra i due linguaggi ci sia ben di più di una qualche apertura occorrerebbe un intero articolo. Mi limito perciò a ricordare qui di seguito alcuni importanti esempi.
Secondo il letterato greco Nasos Vaghenàs "Borges si esprime in poesia servendosi dei mezzi della prosa, di una prosa che tra l'altro indossa una maschera ulteriore, quella dello stile saggistico; la sua fama è comunque dovuta più alle opere in prosa che a quelle in poesia, fermo restando che la prosa borgesiana si caratterizza per la sua poeticità, tanto da poterla definire prosa poetica" (2). Non è il solo! Rimaniamo a casa nostra e consideriamo il principio della novella "La Roba": "Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini […] se domandava: ‘Qui di chi è?', sentiva rispondersi: ‘Di Mazzarò [...] Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco". In questo ritmo non si ritrova forse una "poesia in prosa" (così Eugenio Donadoni, ricco e profondo "giudice dei poeti", scrisse Attilio Momigliano)? E la prosa carducciana? Non spicca per il valore della critica (egli è debitore di De Sanctis), bensì in quanto lavorata come poesia, con attenzione alla musica (altra convivenza, dunque) (3). Ma prima di lui e più profondamente di lui è a Leopardi che ci si deve riferire per le tensioni, le sovrapposizioni tra poesia e prosa. E oggi? Si può citare la "prosa poetica" di Giampiero Neri (m. a Milano nel 2023).
-------------
(1) Avendo tanto imparato dal mio Maestro, il compianto prof. Francesco Marani, docente universitario e poeta, a muovermi in un certo "sistema di segni tracciati", ricordo che in una sua poesia, datata 10-4-2010 , retrocedendo nel tempo Egli giunge "fino a un punto d'arresto". E dice: " [...] Vi scorgo un volto [...] che [...] mi guarda fissamente / come se non m'avesse mai lasciato / Era il tempo degli Angeli Custodi." (Falso plurale, Book Editore, 2010, p.97.)
(2) Cfr. J.L.Borges, "L'enigma della poesia e la resurrezione della parola", Il Sole 24 Ore, Domenica, 02/03/2025.
(3) Nell'antichità classica, le pratiche di danza, musica e poesia non erano "pensate" come attività distinte una dall'altra, così come siamo abituati a classificarle oggi, ma ognuna di queste arti non poteva prescindere dalle altre. Il coreuta del teatro greco era nello stesso tempo poeta-attore, musicista e danzatore.
LA SCOMPARSA DI PASQUALE MAFFEO
Uno scrittore per amico
Se n'è andato a fine settembre il mio caro amico Pasquale Maffeo, scrittore poeta drammaturgo traduttore critico letterario. Ci eravamo conosciuti tanti anni fa in ambiente scolastico: lui presidente, io commissario in un esame di Stato a Imola. La nostra amicizia è poi cresciuta sul filo di comuni interessi e visioni letterarie: notevole il suo romanzo Prete Salvatico (1989), che lo ha qualificato indagatore di anime, ma è stata soprattutto la sua produzione poetica a sedurmi, dove il versus ha proclamato la più rigorosa separazione dall'opera in prosa: ricordo, in particolare, le raccolte Straniero alla finestra (1978, "Straniero, alla finestra guardo il mondo / che irride queste esilio, mia vittoria") e Diciture (2006, "Grondano le aurore / su chi nasce su chi muore"). Scrisse la prefazione del mio Davanti al sasso, primo libro della collana, nata nel 1994 e chiusa agli inizi del nuovo secolo, di cui egli assunse la direzione dopo che la stessa ebbe ospitato la sua raccolta di articoli Interni del Novecento, prefata da Simonetta Bartolini. La tiravamo lunga nelle nostre chiacchierate sui colloqui che si stabiliscono scrivendo ed anche per questa consuetudine finii con l'affiancarlo, indegnamente, nella commissione di un premio di poesia. Purtroppo, dopo il suo trasferimento da Modena verso il golfo di Gaeta, rimanendo egli sempre fedele alla sua vocazione di scrittore mentre io sentivo il bisogno di capire se avessi mai una qualche vocazione, ci siamo persi un po' di vista: ci sentivamo in occasione del Natale per scambiarci gli auguri: mi rispondeva al telefono, con voce soleggiata e gentile, la sua premurosa compagna di vita, moglie e madre, la signora Gianna. Concludendo l'ultimo tratto del nostro dialogo, Pasquale mi salutò così: "Non sto bene in salute, ma sono sereno": c'era, in quelle sue parole, la speranza, del poeta, di "orti d'oro", "orti azzurri". Abbiamo perso, con lui, uno scrittore teso a far "rifulgere una civiltà": il suo cospicuo fondo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, conservatore il prof. Giuseppe Lupo, fornirà certo, negli anni a venire, preziosi spunti e riferimenti per documentati studi sul passo del narratore, sul calore del poeta, sui "linguaggi separati" dell'uno e dell'altro; sulla "lievitazione" che ha "dato respiro" ai suoi volumi, fino al suo ultimo romanzo, una storia tra il "male che sfregia" e lo splendore divino: La risata dell'Invisibile (2019).
Correggio, ottobre 2024
L'OPZIONE PRATOLINI E L'ARTE DI FARSI LEGGERE
Se ad alcuni sembra che certe immagini disturbino le copertine (e perciò l'occhio si offende) - ma Protagora dà ragione a tutti -, anche un seguace del filosofo di Abdera dovrebbe ammettere che serpeggia, nella narrativa contemporanea, una certa povertà inventiva. Ah (!), direbbe subito un informatissimo lettore pronto a prenderci in castagna: "Questo lo aveva già scritto Eugenio Donadoni nella sua Breve storia della letteratura italiana, Signorelli, p.353. E correva l'anno 1941!". E giù il rimprovero, dunque, a ragione, almeno per la mancanza delle virgolette: «certa povertà inventiva». Già, proprio così. E allora? Allora io, nel mio piccolo, simpatizzo per lo scrittore moderno che soddisfa a due condizioni, due requisiti: 1) il rispetto di quello che chiamerei l'opzione Pratolini: "Non si racconta, almeno per quello che mi riguarda, ciò che non si conosce, anche se esiste, e io mi inchino, chi può scrivere quello che non conosce e che inventa. Io sono invece per scrivere ciò che si conosce o che si inventa all'interno della nostra conoscenza, della nostra esperienza" (da un'intervista romana di Luciano Luisi del maggio 1988); 2) il possesso dell'«arte di farsi leggere» (ora faccio il mio dovere e metto i caporali: v. E. Donadoni, ibid.). Qualcuno dirà (in effetti, è stato detto, ma non ho il tempo di controllare): c'è chi scrive trasformando le disgrazie altrui in diritti d'autore. Ma è solo una supposizione, forse l'ombra di un sospetto... un'ombra sorta dall'ansia di risalire all'ordito del racconto.
Recensione di "Massimilla MCMLXXV":
https://lacasadicartapapirnatahisa.wordpress.com/2021/10/13/bilogia-appena-uscita/
Recensione di "Solo uno sbirro":
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=158194942658131&id=100054028772530
(In occasione dell'uscita da Macchione Editore della mia seconda raccolta di poesie Sotto il manto di Elias, marzo 2025)
Diverse le sintassi, diversi i tessuti, certamente. E forse il poeta è, innanzi tutto, un lettore lentissimo, perché gusta (quando ritenga lo meritino, altrimenti si ferma) le singole "righe", le singole "pagine", manifestando, così, amore per la parola e per il suo senso profondo (1). Ma a sorreggere la tesi che tra i due linguaggi ci sia ben di più di una qualche apertura occorrerebbe un intero articolo. Mi limito perciò a ricordare qui di seguito alcuni importanti esempi.
Secondo il letterato greco Nasos Vaghenàs "Borges si esprime in poesia servendosi dei mezzi della prosa, di una prosa che tra l'altro indossa una maschera ulteriore, quella dello stile saggistico; la sua fama è comunque dovuta più alle opere in prosa che a quelle in poesia, fermo restando che la prosa borgesiana si caratterizza per la sua poeticità, tanto da poterla definire prosa poetica" (2). Non è il solo! Rimaniamo a casa nostra e consideriamo il principio della novella "La Roba": "Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini […] se domandava: ‘Qui di chi è?', sentiva rispondersi: ‘Di Mazzarò [...] Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco". In questo ritmo non si ritrova forse una "poesia in prosa" (così Eugenio Donadoni, ricco e profondo "giudice dei poeti", scrisse Attilio Momigliano)? E la prosa carducciana? Non spicca per il valore della critica (egli è debitore di De Sanctis), bensì in quanto lavorata come poesia, con attenzione alla musica (altra convivenza, dunque) (3). Ma prima di lui e più profondamente di lui è a Leopardi che ci si deve riferire per le tensioni, le sovrapposizioni tra poesia e prosa. E oggi? Si può citare la "prosa poetica" di Giampiero Neri (m. a Milano nel 2023).
-------------
(1) Avendo tanto imparato dal mio Maestro, il compianto prof. Francesco Marani, docente universitario e poeta, a muovermi in un certo "sistema di segni tracciati", ricordo che in una sua poesia, datata 10-4-2010 , retrocedendo nel tempo Egli giunge "fino a un punto d'arresto". E dice: " [...] Vi scorgo un volto [...] che [...] mi guarda fissamente / come se non m'avesse mai lasciato / Era il tempo degli Angeli Custodi." (Falso plurale, Book Editore, 2010, p.97.)
(2) Cfr. J.L.Borges, "L'enigma della poesia e la resurrezione della parola", Il Sole 24 Ore, Domenica, 02/03/2025.
(3) Nell'antichità classica, le pratiche di danza, musica e poesia non erano "pensate" come attività distinte una dall'altra, così come siamo abituati a classificarle oggi, ma ognuna di queste arti non poteva prescindere dalle altre. Il coreuta del teatro greco era nello stesso tempo poeta-attore, musicista e danzatore.
LA SCOMPARSA DI PASQUALE MAFFEO
Uno scrittore per amico
Se n'è andato a fine settembre il mio caro amico Pasquale Maffeo, scrittore poeta drammaturgo traduttore critico letterario. Ci eravamo conosciuti tanti anni fa in ambiente scolastico: lui presidente, io commissario in un esame di Stato a Imola. La nostra amicizia è poi cresciuta sul filo di comuni interessi e visioni letterarie: notevole il suo romanzo Prete Salvatico (1989), che lo ha qualificato indagatore di anime, ma è stata soprattutto la sua produzione poetica a sedurmi, dove il versus ha proclamato la più rigorosa separazione dall'opera in prosa: ricordo, in particolare, le raccolte Straniero alla finestra (1978, "Straniero, alla finestra guardo il mondo / che irride queste esilio, mia vittoria") e Diciture (2006, "Grondano le aurore / su chi nasce su chi muore"). Scrisse la prefazione del mio Davanti al sasso, primo libro della collana, nata nel 1994 e chiusa agli inizi del nuovo secolo, di cui egli assunse la direzione dopo che la stessa ebbe ospitato la sua raccolta di articoli Interni del Novecento, prefata da Simonetta Bartolini. La tiravamo lunga nelle nostre chiacchierate sui colloqui che si stabiliscono scrivendo ed anche per questa consuetudine finii con l'affiancarlo, indegnamente, nella commissione di un premio di poesia. Purtroppo, dopo il suo trasferimento da Modena verso il golfo di Gaeta, rimanendo egli sempre fedele alla sua vocazione di scrittore mentre io sentivo il bisogno di capire se avessi mai una qualche vocazione, ci siamo persi un po' di vista: ci sentivamo in occasione del Natale per scambiarci gli auguri: mi rispondeva al telefono, con voce soleggiata e gentile, la sua premurosa compagna di vita, moglie e madre, la signora Gianna. Concludendo l'ultimo tratto del nostro dialogo, Pasquale mi salutò così: "Non sto bene in salute, ma sono sereno": c'era, in quelle sue parole, la speranza, del poeta, di "orti d'oro", "orti azzurri". Abbiamo perso, con lui, uno scrittore teso a far "rifulgere una civiltà": il suo cospicuo fondo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, conservatore il prof. Giuseppe Lupo, fornirà certo, negli anni a venire, preziosi spunti e riferimenti per documentati studi sul passo del narratore, sul calore del poeta, sui "linguaggi separati" dell'uno e dell'altro; sulla "lievitazione" che ha "dato respiro" ai suoi volumi, fino al suo ultimo romanzo, una storia tra il "male che sfregia" e lo splendore divino: La risata dell'Invisibile (2019).
Correggio, ottobre 2024
L'OPZIONE PRATOLINI E L'ARTE DI FARSI LEGGERE
Se ad alcuni sembra che certe immagini disturbino le copertine (e perciò l'occhio si offende) - ma Protagora dà ragione a tutti -, anche un seguace del filosofo di Abdera dovrebbe ammettere che serpeggia, nella narrativa contemporanea, una certa povertà inventiva. Ah (!), direbbe subito un informatissimo lettore pronto a prenderci in castagna: "Questo lo aveva già scritto Eugenio Donadoni nella sua Breve storia della letteratura italiana, Signorelli, p.353. E correva l'anno 1941!". E giù il rimprovero, dunque, a ragione, almeno per la mancanza delle virgolette: «certa povertà inventiva». Già, proprio così. E allora? Allora io, nel mio piccolo, simpatizzo per lo scrittore moderno che soddisfa a due condizioni, due requisiti: 1) il rispetto di quello che chiamerei l'opzione Pratolini: "Non si racconta, almeno per quello che mi riguarda, ciò che non si conosce, anche se esiste, e io mi inchino, chi può scrivere quello che non conosce e che inventa. Io sono invece per scrivere ciò che si conosce o che si inventa all'interno della nostra conoscenza, della nostra esperienza" (da un'intervista romana di Luciano Luisi del maggio 1988); 2) il possesso dell'«arte di farsi leggere» (ora faccio il mio dovere e metto i caporali: v. E. Donadoni, ibid.). Qualcuno dirà (in effetti, è stato detto, ma non ho il tempo di controllare): c'è chi scrive trasformando le disgrazie altrui in diritti d'autore. Ma è solo una supposizione, forse l'ombra di un sospetto... un'ombra sorta dall'ansia di risalire all'ordito del racconto.
Recensione di "Massimilla MCMLXXV":
https://lacasadicartapapirnatahisa.wordpress.com/2021/10/13/bilogia-appena-uscita/
Recensione di "Solo uno sbirro":
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=158194942658131&id=100054028772530
Premi letterari
La silloge Contrappunti dell'anima ha ricevuto il premio "Lettura Poetica", Sarzana, dicembre 2024.
Il romanzo Ritorno a Correggio ha ricevuto i seguenti premi:
- Premio Internazionale "Giglio Blu" di Firenze 2019
II Premio in memoria di E. Malosso;
- Premio Letterario Internazionale "Città di Sarzana" 2019
II Premio In Punta di Penna.
Alla mia e-mail di ringraziamento, la presidente del Premio Letterario Internazionale "Città di Sarzana" ha così risposto:
Gentile autore,
noi ringraziamo lei per la qualità della sua opera, per le capacità oratorie dimostrate all'incontro con gli autori e anche per le sue qualità umane, che conoscendola abbiamo potuto apprezzare.
Il lustro a un Premio letterario come il nostro lo danno le conoscenze e le competenze degli autori che vi partecipano e le sue sono di altissima qualità e per questo la ringraziamo ancora per la sua partecipazione, sperando che non sia l'ultima.
Le confermiamo che appena sarà disponibile il suo video, sarà nostra premura inviarglielo.
Augurandole una buona giornata le inviamo le nostre cordialità.
Presidente del Premio Susanna Musetti
Il romanzo Ritorno a Correggio ha ricevuto i seguenti premi:
- Premio Internazionale "Giglio Blu" di Firenze 2019
II Premio in memoria di E. Malosso;
- Premio Letterario Internazionale "Città di Sarzana" 2019
II Premio In Punta di Penna.
Alla mia e-mail di ringraziamento, la presidente del Premio Letterario Internazionale "Città di Sarzana" ha così risposto:
Gentile autore,
noi ringraziamo lei per la qualità della sua opera, per le capacità oratorie dimostrate all'incontro con gli autori e anche per le sue qualità umane, che conoscendola abbiamo potuto apprezzare.
Il lustro a un Premio letterario come il nostro lo danno le conoscenze e le competenze degli autori che vi partecipano e le sue sono di altissima qualità e per questo la ringraziamo ancora per la sua partecipazione, sperando che non sia l'ultima.
Le confermiamo che appena sarà disponibile il suo video, sarà nostra premura inviarglielo.
Augurandole una buona giornata le inviamo le nostre cordialità.
Presidente del Premio Susanna Musetti
Terza puntata di "Romanzi in diretta" (a cura di Lucia Caponetto), 9/12/2020.
Ospite della serata: "Schegge d'Ambra nella bassa" di Enrico Messori.
"Autori ai domiciliari".
Intervista di Elisabetta Violani 14/10/2020